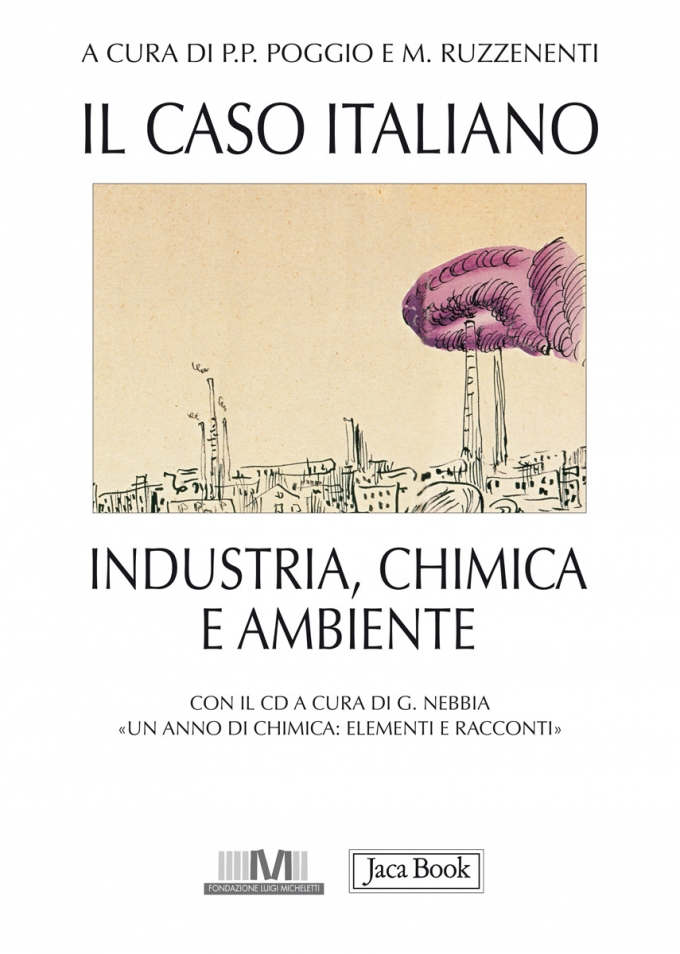«Il caso italiano. Industria, chimica e ambiente» è un librone (con DVD allegato) di oltre 500 pagine scritte in piccolo e nessuna foto. Eppure è un libro da leggere, possibilmente tutto, perché la sua disadorna ricchezza offre materiali importanti per mettere in relazione realtà pensate generalmente come separate, se non opposte - storia industriale e storia ambientale, materie prime e rifiuti, disastri ambientali passati e minacce (ma anche possibili vie d'uscita) future.
Nell’introduzione i due curatori, Pier Paolo Poggio e Marino Ruzzenenti, propongono chiavi di lettura importanti per cogliere le specificità del «caso italiano» evocato nel titolo. Il principale tratto distintivo del rapporto industria-chimica-ambiente consiste nell'aver assunto non di rado la forma di autocolonizzazione. Ernesto de Martino aveva parlato della necessità di studiare anche le «Indie di quaggiù» - pianti rituali, tarantate e altre stranezze dal Sud italiano, inteso come territorio solo confinante con la Modernità. L'antropologa Lynda Dematteo ha parlato di «Indie di quassù» in uno studio sul leghismo, applicando quindi al Nord di oggi (ma dove solo ieri c'erano le «coree»), ricco e iper-industrializzato, categorie e modelli un tempo utilizzati per studiare popoli che ignoravano l'esistenza stessa di fabbriche, supermercati, centrali nucleari, inceneritori e ogni altro tratto che adesso distingue i «Paesi sviluppati». Quasi a chiudere il cerchio, ma passando dal piano dell'analisi culturale a quello della storia ambiental-industriale, qui il colonialismo viene visto come la forma di dominio cui paragonare il rapporto intercorso in Italia tra moderni (industrializzatori) e arretrati (da industrializzare): «I meccanismi sono simili a quelli classicamente coloniali (sfruttamento selvaggio delle risorse umane, naturali ed economiche di un territorio da parte di una potenza straniera dominatrice), ma messi in opera da forze interne, che appartengono allo stesso Paese che si autosfrutta, in un contesto democratico e con il consenso delle forze politiche rappresentative» (p. 10). Questa logica entra a pieno regime negli anni del «miracolo economico», da contemplare qui come stazione in cui un Paese senza petrolio si trasforma nel Paese della petrolchimica. Il resto dell'introduzione (in cui spiccano i dati attuali su una Padania in via di desertificazione, la formula «negazionismo in materia ambientale» e una critica penetrante alle insofferenze delle élite neo-coloniali nei confronti della «sindrome-Nimby») e buona parte della prima sezione del libro, dedicata a storie di «casi», mostrano che «autocolonizzazione» non è una semplice provocazione intellettuale.
Gli studi di caso passati in rassegna sono italiani, anzi italianissimi, sia dove si ricostruisce la specificità dell'industrializzazione nazionale e il suo debito con l'energia idraulica e idroelettrica (Stefania Barca ci ricorda che non è stata la macchina a vapore a fare la rivoluzione industriale, da noi, ma le pale del mulino e le turbine – e che anche in Gran Bretagna le cose sono andate diversamente da come si immagina), sia dove si racconta le origini (nella sensibilità estetica delle élite di inizio Novecento) della tutela del patrimonio naturalistico, sia dove si ripercorrono alcune delle crisi ambientali causate da industrie chimiche in Italia. Eccoci nel profondo del «Cuore di tenebra» italiano.
Le centinaia di pagine dedicate all'Acna (val Bormida), alla Rumianca di Pieve Vergonte (val d'Ossola), all'industrializzazione nella Valle del Sacco (nel frusinate) e alla produzione del piombo tetraetile (soprattutto a Trento) sono tasselli ben documentati per una futura storia sistematica dell'impatto dell'industrializzazione diffusa in Italia. Non c'è Porto Marghera, non c'è Porto Torres, non c'è Taranto, non c'è Praia a Mare, non c'è Brescia, non c'è Gela, non c'è Casale Monferrato e non ci sono molti altri possibili casi, ma ci sono elementi per individuare le fortissime somiglianze di famiglia. In effetti, gli approfondimenti che vengono forniti sono necessari, ma forse lo è ancora di più la capacità di individuare invarianti e tendenze ricorrenti, come soprattutto Poggio e Ruzzenenti fanno nei rispettivi articoli.
Il montaggio con cui Ruzzenenti racconta la storia merceologica, industriale e italiana del piombo tetraetile è molto efficace: la centralità della benzina per la nostra civiltà e il nostro immaginario è tale che una storia dell'additivo che si è imposto per impedire ai motori di «battere in testa», appunto il piombo tetraetile, è una storia di vita quotidiana, ben spiegata anche se dura da accettare. Eppure, si deve prendere atto che a inizio secolo negli Stati Uniti decisero di produrre quella sostanza (anche se alternative meno pericolose esistevano), che in Italia per farlo sono morte a Trento, e spesso prima finite nel manicomio di Pergine per via dell'impatto devastante e noto del piombo sul sistema nervoso, un numero non si sa quanto alto di persone, e che tutto questo è successo fino alla fine degli anni Settanta nel silenzio quasi assoluto. Tra il '64 e il '65 uno sciopero contro il licenziamento di 40 lavoratori per scarso rendimento (in realtà malati) fallisce per isolamento e per fame. Dal '69 si organizzano manifestazioni e assemblee, in esse un medico dell'Università di Padova dice che le corsie dell'istituto di medicina sono sempre piene di operai della Sloi, uno studente di sociologia assimila la struttura aziendale a quella dei campi dei concentramenti e il disinteresse della popolazione a quello per gli ebrei nei ghetti. Matti da internare gli operai ma matti da non ascoltare quelli che lo dicono, perché la fabbrica sarà chiusa solo nel 1978, quando un'esplosione minaccerà di coinvolgere le cisterne di piombo e, con esse, tutta la città.
Il silenzio è un protagonista di molti degli articoli raccolti. Silenzio strategico da parte di chi sa, silenzio più difficile da definire (ci torno sotto) da parte di chi ha capito sulla pelle propria e dei colleghi ma non molla e anzi spesso se la prende con chi parla, silenzio complice o ignorante di istituzioni e partiti, silenzio prevedibile dei mass-media nei periodi di «normalità» (cioè quando non scoppia qualche cisterna e il male diventa non solo innegabile, ma anche notiziabile), silenzio da inadeguatezza concettuale di università e studiosi vari (gli autori di questo libro, soprattutto l'opera minoritaria dei più anziani, erano e rimangono eccezioni). Chi parla sono i rifiuti di un Paese ad autocolonizzazione avanzata, anzi rivendicata.
In questo contesto, l'articolo di Poggio mette a fuoco due aspetti decisivi: il controllo scientifico sulla tecnoscienza; la servitù volontaria nella tarda modernità.
Come in parte già detto, le lotte per l'ambiente e la salute raccontate in questo e altri articoli sono quasi invariabilmente battaglie perse: le vittorie sono poche e, nel caso, arrivano tardi. Lo sviluppo di una coscienza ambientale si trova in conflitto con un diffuso e radicato «principio di Realtà» che ha avuto e ha nell'equazione «fabbrica=progresso» un simbolo pressoché invincibile. E alla Realtà, in effetti, cosa vuoi dire? Il silenzio appare addirittura logico. In questo confronto impari un ruolo decisivo viene giocato, oltre che da industriali senza scrupoli e funzionari in mala fede, dagli esperti chiamati a verificare la pericolosità degli impianti produttivi.
L'indagine epidemiologica in Valle Bormida del 1992 è condotta sulla base di certificazioni di morte desunte dai dati Istat, una fonte che gli stessi esperti ritengono insufficiente. Ovviamente queste conclusioni saranno abilmente utilizzate dai vari interessi coloniali in gioco, ma questa e altre vicende del genere indicano un problema generale, costituito dalla difficoltà di produrre studi scientifici rigorosi partendo da una base empirica spesso insufficiente o incerta.
La servitù volontaria, invece, è un tema classico della filosofia politica, che indica la preferenza talora accordata a una comoda schiavitù rispetto a una libertà percepita come fonte di problemi e rischi. La servitù volontaria della tarda modernità evidenzia una possibilità più estrema: non è che delle persone accettano lo scambio libertà-benessere («decidi tu Potere per me, non mi interessa essere autonomo, basta che mi fai vivere decentemente»), qui delle persone accettano lo scambio vita-benessere («Fabbrica, per te rischio la salute e anche la vita, basta che fai vivere decentemente me e la mia famiglia). Quello che Poggio afferma è che alla base delle scelte di molti lavoratori e lavoratrici non ci sarebbe sempre e solamente la mancanza di informazioni sufficienti, ma anche uno strato specificatamente culturale, in cui si mescolano rassegnazione e fede nella Macchina. Aggregate, queste scelte sono un elemento fondamentale del consenso all'autocolonizzazione di cui sopra.
La seconda sezione dell'opera è dedicata al rapporto tra ambiente e sistemi politico e mediatico. Per quanto riguarda l'ambito politico, il caso analizzato è quello del PCI. Wilko Graf von Handerberg ripercorre in modo attento scelte, oscillazioni e contraddizioni del principale partito di opposizione davanti agli effetti occupazionali della questione ecologica nel periodo 1972-1991. Ricco e stimolante il contributo di Edgar Meyer sul rapporto tra mass media e rischio ambientale, anche se risulta stridente, rispetto al resto dell'opera, la presentazione del conflitto ambientale come un «problema» (pp. 302-303). Nel caso italiano, almeno fino a pochissimi anni fa, il conflitto ambientale appare semmai incomprensibilmente raro, se rapportiamo le mobilitazioni di operai e popolazione, nonché lo spazio dedicato al tema dai mass media, all'impatto reale su salute e ambiente delle moltissime industrie fortemente inquinanti (del resto proprio questa sproporzione motiva il riferimento all'autocolonizzazione e alla servitù volontaria). Il fatto che oggi, in taluni casi, ci possa essere una sensibilità sproporzionata rispetto ai rischi reali costituisce un problema che non pare possa essere disgiunto dal modo in cui sono state «gestite» le vicende raccontate nei precedenti capitoli, e da Meyer stesso nella prima parte del suo testo.
La sezione dedicata a Giorgio Nebbia e il DVD allegato («Un anno di chimica: elementi e racconti») racchiudono lo strato cosmologico dell'opera. Nebbia inquadra chimica e produzione di merci entro il ciclo più ampio degli scambi che uniscono attività umane e ambiente. In tale prospettiva, tutte le attività economiche consistono nel prelevare dei beni materiali dai corpi naturali e nel trasformarli in merci; usate (e non «consumate», mica spariscono!), esse diventano rifiuti e questi, nella loro porzione non depurata e non riciclata, «fanno ritorno» all'ambiente. A ben guardare, si parla di inizio e fine delle cose, e il fatto che sia scritto tutto in minuscolo, entro una prospettiva di sobrio materialismo scientifico, non dovrebbe far perdere di vista l'ampiezza davvero inusuale del discorso. Qui la capacità del libro di aiutare a mettere in relazione realtà pensate generalmente come separate, se non opposte, è nutrita da competenze e capacità narrative davvero uniche. In questi articoli, ma soprattutto nel DVD, il rapporto industria-chimica-ambiente viene non solo denunciato per quello che è stato o è (come nel «caso Seveso», cui viene dedicato un testo incisivo), ma visto anche per come dovrebbe essere, con espliciti riferimenti alla tecnologia sociale di Lewis Mumford. In certo modo, questa sezione offre le categorie per ricomprendere i capitoli precedenti, prevalentemente dedicati a denuncia e analisi, entro una prospettiva più ampia e «positiva».
Questo intreccio di competenze scientifiche, vivacità intellettuale, impegno e proposta politica ha caratterizzato anche l'opera di Laura Conti, una delle madri nobili dell'ambientalismo italiano. Quella che emerge è una figura singolare e affascinante, capace di criticare la concezione del rapporto terra-lavoro in Marx, di lavorare al testo di legge sulla caccia, di scrivere testi di educazione ambientale e molto, molto altro, sempre da protagonista entro una rete di intellettuali-scienziati italiani di altissimo livello. Tra i vari contributi, ricchi e complementari (anche se i disaccordi non mancano), spicca quello di Enzo Tiezzi per la capacità di trasmettere non solo l'opera, ma l'identità di una persona che merita di essere letta e riscoperta.